
Canaletto 1697-1768, Museo di Roma, fino al 19 agosto 2018. Le imbarcazioni scivolano senza sforzo, quasi il Canal Grande fosse un nastro trasportatore (Il Canal Grande da nord, verso il ponte di Rialto, 1725, Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli); Santa Maria della Carità regola i traffici di cose e persone dentro e fuori di sé (Il Canal Grande con Santa Maria della Carità, 1726, Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli); il bacino di San Marco è colmo del laborioso, si direbbe produttivo rituale del Bucintoro, il natante rosso porpora in alto a destra, nel giorno dell’Ascensione (Bucintoro di ritorno al Molo il giorno dell’Ascensione, 1729, Museo Pushkin).
Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, va in giro per Venezia, ispeziona calli, canali e campielli e, ispirato dalle vedute romane di Van Wittel, allo stesso modo di Carlevarijs piazza la sua camera ottica in posizioni impossibili; di poco ruotandola o spostandola cattura più prospettive contigue dello stesso scenario architettonico da altrettanti punti di vista; infine di ciascuna prospettiva disegna i contorni, ricalcando l’immagine impressa sullo schermo trasparente. Poi certo, come e più di altri vedutisti contemporanei e successivi, è anche un pittore; nel suo studio, su quegli schizzi prospetticamente perfetti e pieni di particolari è capace di aggiungere luce, ritmare i chiaroscuri architettonici e rendere le mille, improvvise variazioni di tonalità dello stesso colore che agitano il cielo e la superficie dell’acqua. Ma non è tutto, anzi è ancora niente.
abituato alle scenografie teatrali e corrotto dalla pratica del “capriccio” – genere pittorico che riunisce illusionisticamente nella stessa veduta elementi di paesaggio, monumenti e rovine, quando realmente esistenti mai vicini tra loro – unisce e deforma le prospettive, corregge i difetti ai margini, falsifica proporzioni, immagina punti di vista impossibili, come in un grandangolo fotografico affianca edifici che nessun occhio umano potrebbe cogliere insieme. Pare voglia conferire all’immagine della città la perfezione dell’unità, quando la città vera, seppure rodata da millenario splendore, presenta sempre qualche crepa, una caduta di stile di qua, qualcosa che sfugge al senso di là.
Proprio questa unità in sé conclusa sembra interessare al pittore e ai suoi committenti, italiani e stranieri, smaniosi di arredare con le sue vedute le loro sontuose dimore; l’idea che, assente l’uomo come individuo ma presente come ingranaggio, il paesaggio urbano sia un meccanismo perfetto messo in moto una volta per tutte, autonomo e funzionante senza bisogno dell’intervento di alcuno, una catena oleata di relazioni e merci che nessuno immagina possa fermarsi. Forse una delle idee moderne di città e società partorite dall’illuminismo, che ci attira nei vedutisti del settecento perché per noi ancora ben attuale.
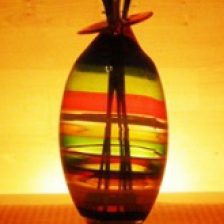

Lascia un commento