![]() Quando al suo interno fu celebrato l’ultimo spettacolo di venationes, nel 523 d. C., pare per celebrare il consolato di un certo Anicius Maximus, il Colosseo era già da tempo in rovina, come l’Impero d’altronde, danneggiato nell’arena e in molta parte degli anelli, nei colonnati, nelle strutture di servizio, nei sotterranei e nei canali di scolo, complici i numerosi terremoti del V secolo (non c’è accordo unanime ma i più devastanti si ipotizzano quelli del 443, 484, 508 d. C.. Ne seguiranno tantissimi altri durante tutto il resto del primo millennio con effetti sul monumento, fino a quello del 1349 che ha tirato giù il bel pezzo di gratinate che guardava al Celio).
Quando al suo interno fu celebrato l’ultimo spettacolo di venationes, nel 523 d. C., pare per celebrare il consolato di un certo Anicius Maximus, il Colosseo era già da tempo in rovina, come l’Impero d’altronde, danneggiato nell’arena e in molta parte degli anelli, nei colonnati, nelle strutture di servizio, nei sotterranei e nei canali di scolo, complici i numerosi terremoti del V secolo (non c’è accordo unanime ma i più devastanti si ipotizzano quelli del 443, 484, 508 d. C.. Ne seguiranno tantissimi altri durante tutto il resto del primo millennio con effetti sul monumento, fino a quello del 1349 che ha tirato giù il bel pezzo di gratinate che guardava al Celio).
Da quel momento la lenta fine del Colosseo, e contemporaneamente la sua salvezza almeno sotto forma di rudere, sono da attribuire, ci sembra, alle sue dimensioni, proibitive per la manutenzione di un’autorità che sia meno di un Impero che veda in esso una qualche utilità, e tali però da renderne lentissima la consunzione, nonostante secoli di abbandono, terremoti e spoliazioni; al fatto di essere rimasto fuori la città medievale, piccola e contrita sulle sponde del Tevere, confinata in una porzione di Campo Marzio, circostanza che lo ha reso sì esposto agli agenti atmosferici e all’asporto di materiali, ma che gli ha anche evitato di scomparire del tutto, inurbato sotto nuove strutture, come successo a moltissimi edifici, teatri ed anfiteatri romani (si pensi a quello di Lucca).
Al fatto infine – e questa la novità degli ultimi decenni di sondaggi e indagini degli archeologi sotto la responsabilità del direttore Rossella Rea – di essere diventato, soprattutto sotto le arcate a livello dell’arena, sede di attività artigianali e abitazioni sin dalla metà del VI secolo d.C.. Presenza residenziale che ha il suo culmine nel XI secolo, quando la chiesa di Santa Maria Nova nel Foro, proprietaria del sito, non esita ad affittare i fornici a fabbri, calzolai, operai, carrai, calcinai.
Poi la trasformazione in fortezza da parte dei Frangipane nel XII secolo, durante il periodo delle beghe cittadine tra grandi famiglie; proseguendo, le spoliazioni di materiali durante il Rinascimento e nel Seicento, le più massicce tra tutte quelle da sempre subite, utili al fervore edilizio del Papato. E così di seguito fino al settecento, quando per la prima volta si fa strada, sotto la spinta della cultura europea, un’idea di rispetto, recupero e conservazione nei confronti dell’antichità classica. In mezzo, a fasi alterne, l’Anfiteatro Falvio conosce abbandono, vegetazione, crolli.
Questo documenta la mostra Colosseo un’icona, fino al 7 gennaio 2018 all’interno del monumento, attraverso reperti, disegni, dipinti, modelli ricostruttivi; ma anche il suo ingresso nell’immaginario universale nel novecento attraverso il cinema, la fotografia, il fumetto i videogiochi e persino la pop art. http://www.coopculture.it/events.cfm?id=611
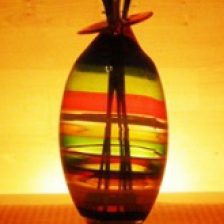

Lascia un commento