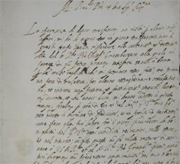 La Fondazione Sorgente Group espone nei suoi spazi di via del Tritone alcuni codici e autografi antichi, accanto a coevi strumenti scientifici e di osservazione astronomica messi a disposizione dal Museo Astronomico e Copernicano dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, allo scopo di dare giusto risalto all’impegno finanziario profuso nel salvare, restaurare e mettere sul web, a disposizione degli studiosi, i tesori documentali del Fondo Clavius, recuperato ai Gesuiti nel 1948 e conservato presso la Pontificia Università Gregoriana.
La Fondazione Sorgente Group espone nei suoi spazi di via del Tritone alcuni codici e autografi antichi, accanto a coevi strumenti scientifici e di osservazione astronomica messi a disposizione dal Museo Astronomico e Copernicano dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, allo scopo di dare giusto risalto all’impegno finanziario profuso nel salvare, restaurare e mettere sul web, a disposizione degli studiosi, i tesori documentali del Fondo Clavius, recuperato ai Gesuiti nel 1948 e conservato presso la Pontificia Università Gregoriana.
Al centro opere e carteggi originali di Galileo Galilei, e dei gesuiti astronomi, entrambi legati al Collegio Romano, Cristoforo Clavio (1538-1612) corrispondente di Galileo, e Angelo Secchi (1818-1878). Per capire l’importanza per la storia della scienza di questi documenti un rapido quanto impreciso quadro storico.
Poco prima di morire, nel 1543 Niccolò Copernico dà alle stampe il De Revolutionibus orbium coelestium libri sex, nel quale, in base ad annose osservazioni e calcoli accurati – suoi e degli astronomi che l’avevano preceduto -, e soprattutto senza riguardo per Aristotele, Tolomeo, San Tommaso e Sacra Scrittura, afferma quanto segue: le sfere celesti non hanno orbite uniche; il centro della Terra non è il centro dell’universo ma solo dei corpi pesanti e della Luna; i pianeti, e la Terra è un pianeta, si muovono in orbita intorno al Sole che è il vero centro dell’universo, mentre i moti diurno e annuale di questo non sono che un effetto apparente di moti autentici della Terra intorno al proprio asse e di questo asse rispetto al piano dell’orbita di rivoluzione; la distanza tra il Sole e la Terra è del tutto trascurabile rispetto a quella tra la Terra e le stelle fisse nel firmamento.
Tutta questa indigesta novità non avrebbe impedito nell’ultimo scorcio del ‘500 che i calcoli sulla durata media dell’anno solare contenuti nel De Revolutionibus diventassero la base per correggere le falle del calendario giuliano nella riforma voluta dal papa Gregorio XIII e da lui affidata ad una commissione di eminenti matematici e astronomi, presieduta proprio dal nostro professore gesuita del Collegio Romano, Cristoforo Clavio; il nuovo calendario licenziato nel 1582, appunto col aggettivo “Gregoriano”, è ancora oggi in uso presso la maggior parte degli Stati.
Un’apertura culturale, quella di Clavio, che avrebbe continuato a manifestarsi nel pieno appoggio espresso dalle sue missive in risposta a Galileo durante il 1610. E Galileo, ormai da tempo sulla scia di Copernico, per conto suo nient’altro aveva fatto che invitarlo a puntare il cannocchiale verso il cielo e a scoprire da sé come Giove era corredato di satelliti (quindi esistevano altri centri di rotazione celeste) e come la luna era tutt’altro che liscia e levigata, ovvero piena di valli e montagne, e da solo imparare che lassù insomma c’era più confusione di quanta Aristotele insieme al sistema tolemaico avrebbero potuto sopportare.
Purtroppo Clavio muore nel 1612 e dalla sua eminente posizione non fa in tempo a risparmiare a Galileo il primo processo di eresia del 1616, innescato da un’omelia al vetriolo del domenicano Padre Tommaso Caccini, pronunciata in Santa Maria Novella un paio di anni prima, durante quale non si poté evitare di sentire che la matematica era un’arte diabolica.
E dire che Giovanni Paolo II, durante la revisione del processo allo scienziato, nel 1993 ebbe modo di affermare che “Una delle cause della condanna di Galileo” è da cercare nel fatto che a quel tempo “la maggioranza dei teologi non percepiva la distinzione formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il che indusse a trasporre indebitamente nel campo della dottrina della fede una questione di fatto appartenente alla ricerca scientifica”. Qualcosa non torna. http://www.fondazionesorgentegroup.com/mostre_23.html
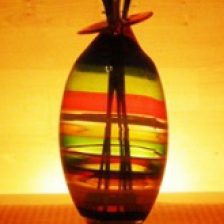

Lascia un commento