 Fino al 20 settembre alle Scuderie di Quirinale la mostra di circa 300 opere di arte islamica scelte tra le migliaia della collezione costituita per decenni dal facoltoso sceicco kuwatiano Nasser Sabah al-Ahmad al-Sabah – primo ministro fino alle dimissioni nel 2011 – e da sua moglie Hussah Sabah al-Salim al-Sabah. Una carrellata puntuale (stucchi, tessuti, vetri, oggetti in metallo, avorio, cristallo di rocca, legni, ceramiche, gioielli, miniature) su mille e quattrocento anni di storia dell’islam moltiplicati per un territorio vastissimo che dalla Spagna arriva al Subcontinente indiano e alla Cina.
Fino al 20 settembre alle Scuderie di Quirinale la mostra di circa 300 opere di arte islamica scelte tra le migliaia della collezione costituita per decenni dal facoltoso sceicco kuwatiano Nasser Sabah al-Ahmad al-Sabah – primo ministro fino alle dimissioni nel 2011 – e da sua moglie Hussah Sabah al-Salim al-Sabah. Una carrellata puntuale (stucchi, tessuti, vetri, oggetti in metallo, avorio, cristallo di rocca, legni, ceramiche, gioielli, miniature) su mille e quattrocento anni di storia dell’islam moltiplicati per un territorio vastissimo che dalla Spagna arriva al Subcontinente indiano e alla Cina.
Di fronte al valore inestimabile di siffatto patrimonio e alla necessità di portarlo a conoscenza del mondo, anche in una sede istituzionale come le Scuderie, è necessario comunque riflettere su quanto del suo prestigio storico e culturale rischiari di mecenatismo gli esponenti di una dinastia (Nasser è nipote dell’attuale Emiro) che domina in varie forme il Kuwait dal XVIII secolo, indenne al dominio ottomano, al protettorato britannico e alle diatribe tra fazioni religiose, con un territorio senza una goccia di acqua ma adagiato su un mare di petrolio; il santo petrolio in forza del quale da una parte si è resa contigua all’Occidente, dall’altra come le altre monarchie del Golfo forse trama quale munifica e occulta finanziatrice di chissà che pedine sullo scacchiere medio orientale.
Una monarchia il Kuwait, ironicamente definita costituzionale (dal 1961 ha una Costituzione in effetti), in cui l’Emiro, supremo capo dello stato, sceglie premier e ministri tra i propri familiari; un apparato costruito sulla ricchissima oligarchia del petrolio che governa una popolazione in gran parte costituita da immigrati senza alcun diritto di cittadinanza.
Quando nel 1990 Saddam Hussein con la scusa di una vecchia disputa territoriale invase il Kuwait provocando la reazione veemente di una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, la collezione al-Sabah fu quasi del tutto trafugata e portata a Baghdad patendo pure qualche perdita. Oggi, completamente recuperata ed arricchita, conta circa 35000 pezzi e lustra l’immagine di una cricca di privilegiati che approfitta della opacità ai diritti umani e civili della propria società ma che ha studiato a Londra e a Ginevra, vive di accordi con i governi dei paesi industriali e sa come blandire la sensibilità occidentale.
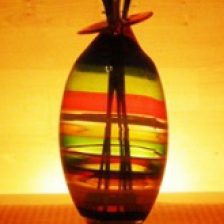

Lascia un commento